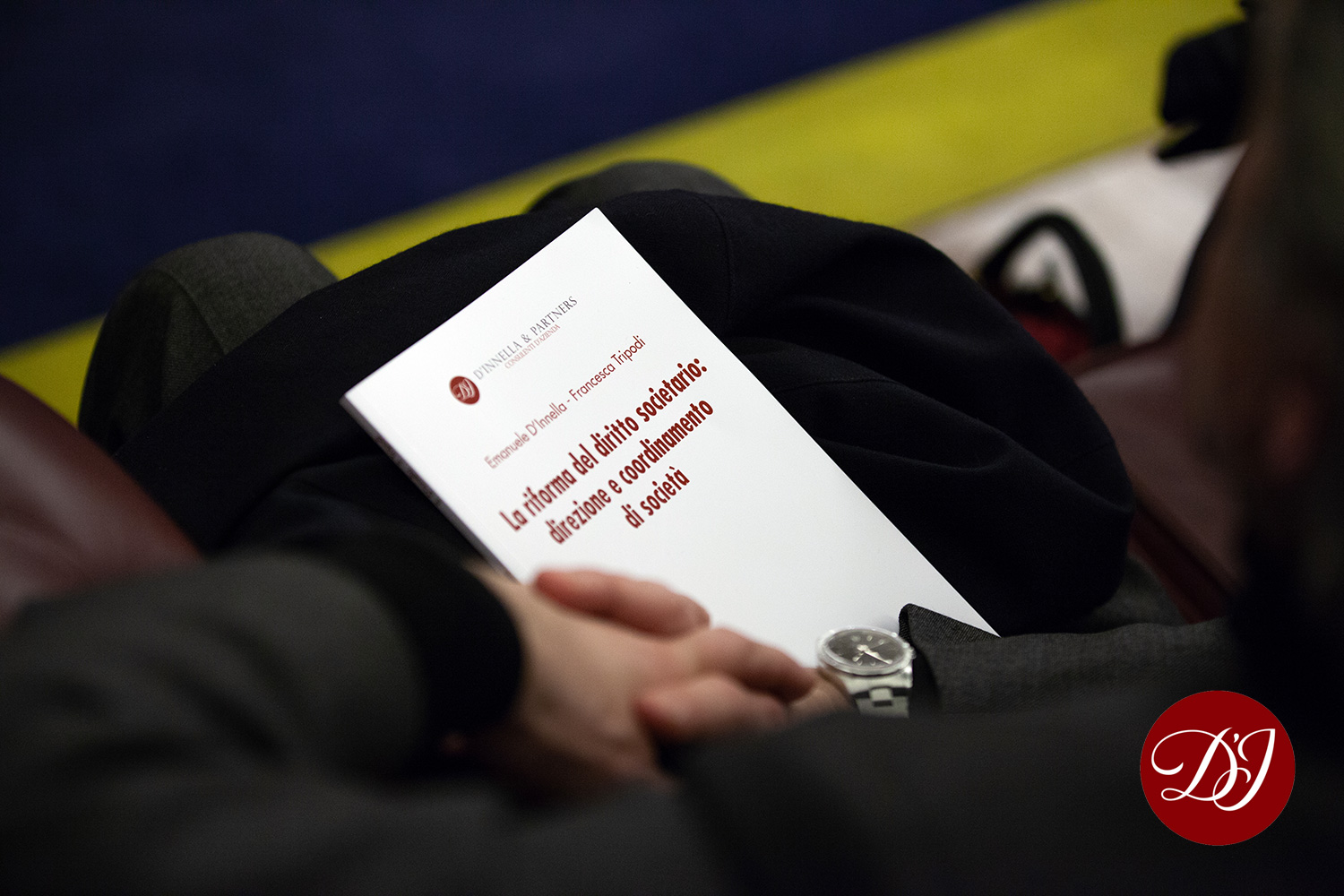
di Francesca Tripodi ed Emanuele D’Innella
Le imprese italiane attive nell’industria e nei servizi di mercato[1] sono 4,4 milioni e occupano 16,5 milioni di addetti. Il 5% di queste imprese è organizzato in strutture di gruppo: sono infatti 219.769 le imprese organizzate in gruppi di imprese (99.268 gruppi), con 5,7 milioni di addetti.
E’ da sempre sotto gli occhi di tutti noi, che ogni giorno ci misuriamo con le realtà imprenditoriali italiane, che il gruppo di imprese è un “fatto aziendale”. Ma come risolvere quel dissidio da sempre presente nel nostro ordinamento tra “unità economica del gruppo” e “autonomia giuridica delle singole società” e, al contempo, contemperare efficacemente le esigenze di trasparenza degli assetti proprietari e di tutela dei soci di minoranza e dei creditori delle società controllate?
Il nostro impianto normativo non poteva più prescindere dal riconoscimento ufficiale, giuridico ed economico, dei gruppi di impresa, finalmente recepito dal nostro legislatore nell’ambito della riforma del diritto societario del 2004 negli articoli 2497 e seguenti del codice civile, dedicati proprio all’attività di “direzione e coordinamento di società”.
Si è parlato di questo corpo di norme come di una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma del 2004; qualcuno l’ha addirittura definita come una “rivoluzione copernicana”, condotta da un legislatore “illuminato” che, per la prima volta, ha tentato di costruire una disciplina organica intorno al tema dei gruppi d’imprese e le annose questioni ad esso connesse, che da troppo tempo riempivano le pagine di libri e riviste, in un gioco di forza tra aziendalisti ed una giurisprudenza altalenante, alla ricerca di una certezza del diritto che sino a quel momento appariva ancora troppo lontana da raggiungere.
Con la riforma del 2004, dunque, il gruppo di imprese ha trovato riconoscimento in un impianto normativo improntato a criteri di trasparenza e pubblicità e comunque tale da garantire, grazie alla legittimazione di una “direzione unitaria”, il contemperamento degli interessi del gruppo, delle società controllate ed anche dei soggetti deboli: soci di minoranza e creditori.
Come allora non accogliere con favore questo impianto normativo che prevede espressamente una responsabilità della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (generalmente, ma non necessariamente, la capogruppo) nei confronti del socio o del creditore della società controllata, nell’ipotesi in cui dall’esercizio di tale attività derivi una lesione dei loro diritti in termini di redditività e valore della partecipazione sociale nonché di integrità del patrimonio della società? E come non accogliere con favore anche tutte le altre disposizioni correlate che prevedono specifici obblighi di pubblicità della soggezione all’altrui direzione e di motivazione di ogni decisione sociale influenzata da questa attività, nonché il diritto di recesso per quel socio che veda modificarsi le condizioni di rischio del suo investimento iniziale a causa di un cambiamento successivo dell’assetto del gruppo societario cui originariamente apparteneva?
Quel che è certo è che ormai dobbiamo abituarci ad integrare la storica previsione contenuta nell’art. 2380 bis del codice civile, secondo cui “la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale” con questi nuovi principi su cui orientare la gestione della nostra impresa, reinterpretati alla luce della liceità dell’attività di direzione e coordinamento a cui è soggetta, proprio in quanto i poteri di amministrazione e gestione non risiedono più solo nel suo organo amministrativo ma ancor prima in quello della capogruppo.
Un’importantissima rivoluzione culturale, dunque, di cui dobbiamo tutti necessariamente tener conto per raggiungere l’obiettivo più alto del “buon governo dell’impresa”.
[1] Rilevazione ISTAT sui dati 2017 – Rapporto del 14.10.2019
